
Il giornalista Stefano Pasta è attualmente titolare di un assegno di ricerca al CREMIT (Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla Tecnologia), diretto da Pier Cesare Rivoltella e collabora con il Centro di ricerca sulle relazioni interculturali, diretto da Milena Santerini - entrambi dell’Università Cattolica di Milano. Con lui abbiamo parlato del suo nuovo libro "Razzismi 2.0. Analisi socio-educativa dell’odio online", edito da Morcelliana, Scholé. Ecco cosa ci ha detto.
Razzismi 2.0, come mai questo titolo, perché la parola usata al plurale?
Direi per due ragioni. La prima, è che le performances razziste sono diverse e possono assumere forme differenti. La seconda, collegata, è che per progettare risposte educative efficaci di prevenzione al razzismo, è fondamentale capire a quale tipo di razzismo ci troviamo di fronte, e questa tesi, consegnataci da tempo dagli studi classici sul tema, assume una particolare importanza nel Web. Dire che sono diverse, non significa sminuire l’importanza di alcune forme di razzismo e di parlare scorretto, che potremmo semplicisticamente derubricare a “meno gravi”. Questi atteggiamenti sono comunque legati fra di loro, e tendono tutti alla normalizzazione del discorso razzista e all'accettazione dell'hate speech.
Durante la mia ricerca, ho volutamente analizzato casi di performances razziste diverse. Non soltanto quelle più estreme - per le quali c’è anche una risposta giuridica da chiamare in causa, nella fattispecie la Legge Mancino, raramente applicata nel Web - ma anche quelle in cui la risposta è prettamente educativa: dalla barzelletta antisemita, a chi scherza dandosi del pakistano terrorista… Tutti casi in cui il problema non è tanto, o non solamente, ideologico, ma è anche dato da un modo di stare e comunicare nel Web che è deresponsabilizzato.
Una delle tesi del libro è che i razzismi 2.0 vanno inseriti, in molti casi, all’interno dello spettro di quello che Marc Prensky chiama cyberstupidity, cioè lo stare in rete senza pensare alle conseguenze delle proprie azioni. Ho chattato con molti ragazzi che sono stati, a vario titolo, protagonisti di performances razziste: l’islamofobo, l’antisemita ecc. Ho provato a chiedere loro il perché di quei comportamenti. Molti non ricordavano nemmeno l’episodio, si stupivano di come avessi potuto reperire quell’informazione: al contrario - è noto - ciò che viene scritto nel Web ha proprio la caratteristica di essere incancellabile. La loro risposta era quasi sempre: “ma stavo scherzando, non devi prendermi seriamente”, magari in riferimento a un post in cui si incitava a un atto di genocidio verso una minoranza, o ad altri episodi gravissimi. L’intervento educativo, da mettere in atto in queste circostanze, è quindi quello di insegnare a prendersi sul serio, a valutare le conseguenze: il virtuale è reale. Dunque uno spazio in cui non possiamo permetterci di “non prendere sul serio” quello che affermiamo.
Nel libro parli della necessità di sviluppare una responsabilità nella mediapolis. Come si può trasmettere l’importanza di esprimersi responsabilmente attraverso dei mezzi spesso erroneamente considerati “un’innocua valvola di sfogo”, soprattutto in un momento in cui anche gli stessi giornalisti e istituzioni a volte sottovalutano la potenza delle parole di odio?
Tocchi un tema assolutamente centrale nel dibattito sui razzismi. Detto con uno slogan, dovremmo educare tutti, in particolare i giovani, al passare dall’essere spettatori a essere soccorritori. Le ricerche recenti, infatti, ci mostrano come i ragazzi riconoscono l’hate speech ma non agiscono. Ed è proprio qui, nella zona grigia che il Web va ad aumentare, che è fondamentale intervenire.
Per quanto riguarda invece l’educazione all’informazione, di fronte al digitale ci si potrebbe dividere tra apocalittici e integrati: tra chi aprioristicamente è a favore, e chi è contrario. La realtà è che c’è poco da discutere. Il digitale fa parte delle nostre vite. Volutamente ho citato Apocalittici e integrati di Umberto Eco - che nel 1964 si riferiva all’avvento di un altro media, la televisione -, perché il dibattito di fondo non è cambiato. C’è una grande differenza però: nella società televisiva il nodo cruciale fu educare al pensiero critico di fronte alla notizia. Nel Web questo continua ad essere essenziale ma, in più, oggi ciascuno di noi diventa produttore della notizia. In questo senso, ad esempio, una foto postata su Facebook, che diventa virale, può generare una campagna d’odio. Tutti noi quindi creiamo informazione, ma non tutti noi abbiamo fatto l’esame per diventare giornalisti professionisti. Non voglio dire che il giornalista sia perfetto - e la questione delle fake news lo dimostra - ma nella società 2.0 la potenzialità di produrre notizia è aumentata, e questo aspetto può essere sia negativo che positivo, a seconda di come viene agito.
Il Ministero dell’Istruzione, a inizio 2018, ha emanato il Curriculum sull’educazione civica digitale, composto da 5 aree. Una di queste è proprio l’educazione all’informazione e "pensiero critico" e "responsabilità" sono le parole chiave dell’intero Sillabo. Quel documento - alla cui stesura ha collaborato anche il direttore del CREMIT Pier Cesare Rivoltella, con il quale ho svolto lo studio di cui parlo nel libro - pone delle basi molto interessanti. Nel libro, infatti, in riferimento al Sillabo, ci sono varie proposte su cosa insegnanti, educatori e genitori, possono fare. Il tema dell’educazione è la chiave di risposta, che non può essere solo normativa o repressiva. Certamente la risposta giuridica è necessaria, ma non può bastare, anche in ragione del fatto che nel Web entrano in gioco sistemi giuridici diversi. Negli USA, per fare un esempio, il partito fascista, il Ku Klux Klan e il partito nazista sono associazioni culturali e Facebook, Twitter, Google e Youtube hanno sede lì. Anche quando le norme esistono, inoltre, non sempre il problema si risolve. È il caso della Legge Mancino, di fatto inapplicata nel Web. A questo proposito, mi trovo molto d’accordo con la proposta di Liliana Segre, presentata in Senato, di una commissione che si occupi di questi temi e contrasti l'hate speech online.
Quanto razzismo c’è nella retorica del “alcune culture sono incompatibili per natura”? Come vedi il pericolo che il razzismo possa assumere una forma politicamente corretta, nascosto dietro alla maschera della cultura di origine, senza nemmeno più bisogno di usare le parole “razza” o “biologia”? E quale rapporto c’è con il riemergere di fascismi e nazionalismi?
Innanzitutto, bisogna considerare le caratteristiche del sistema digitale che facilitano la propagazione di odio, dalla velocità 2.0 all’ampiezza di diffusione, dall’analfabetismo emotivo al desiderio di conformità. Occorre poi analizzare come cambia il contenuto del discorso razzista nella società attuale. Non è detto che il nazionalismo coincida con il razzismo, ma certo è che apologie etnocentriche delle società del rancore sono terreno fertilissimo per i pensieri d’odio. Tutti i pensieri “prevenuti” e discriminatori vanno combattuti: spesso l’antisemitismo si associa all’islamofobia, o il discorso sessista si unisce al discorso xenofobo ecc. In tutto il primo ‘900, il razzismo è stato segnato dall’istanza biologica: la superiorità dell’uomo bianco su quello nero, la vicinanza genetica tra l’uomo africano e lo scimpanzé. Nella seconda metà del secolo, invece, l’istanza biologica non è scomparsa, ma è diventata meno importante e si è inserito in modo predominante il cosiddetto razzismo culturalista o differenzialista, latente o implicito. Le retoriche razziste hanno cominciato a essere costruite su base culturale: “i musulmani sono troppo diversi da noi e quindi non possiamo vivere insieme”, “gli ebrei hanno dei valori culturali talmente distanti che forse un po’ se lo meritavano”. Quest’istanza, è presente anche oggi, ed è esattamente quell’anello di congiunzione tra i pensieri del rancore - che poi diventano sia discorsi politici che da bar - e l’incitamento all’odio.
Nel Web, però, è accaduto un fatto nuovo: il “ritorno della razza" su basi non più scientifiche. Prendiamo ad esempio un meme che associa Balotelli o l'ex Ministra Kyenge a una scimmia: nessuno crede realmente che due persone di colore siano parenti stretti dello scimpanzé, ma siamo di fronte a un ritorno della più classica istanza del razzismo biologico, svuotata di credibilità scientifica. Questo modo di parlare e operare irresponsabile ha contribuito a rompere alcuni tabù sociali. Si sono normalizzati la parola e il pensiero razzisti, sono tornati alcuni pensieri che erano stati banditi, con la pretesa di non essere presi sul serio. In questo senso, la senatrice Liliana Segre mi trova assolutamente d’accordo quando parla di “fascistizzazione del senso comune”; dalla testimonianza della senatrice abbiamo imparato come l’indifferenza possa rendere possibile tutto, anche il Male assoluto della Shoah.
Proprio a proposito di questa sottovalutazione, in Myanmar i militari birmani hanno usato Facebook per una campagna che istigava al genocidio dei Rohingya. È lecito, secondo te, pensare che senza un’adeguata moderazione i social potrebbero essere usati per innescare nuovi genocidi?
Le storie dei sistemi più classici e più organizzati di odio, ci insegnano che i media sono sempre un ottimo alleato in questo senso - penso alle riprese cinematografiche delle parate naziste o a radio machete in Ruanda nel 1994. Oggi, in più, non solo usufruiamo tutti dei social ma, come dicevo prima, siamo produttori di notizia. Abbiamo a disposizione un mezzo che può essere sia strumento di libertà che di repressione e controllo. La soluzione è uscire da visioni a priori: il Web non è libero per forza, dipende dall’uso che ne facciamo.
Ci sono stati anche episodi opposti a quello dei Rohingya che hai citato, mi riferisco all’uso di Twitter durante le proteste in Iran di qualche anno fa o all’uso dei social durante le Primavere arabe. Non possiamo più permetterci di considerare Internet come uno spazio alternativo alla vita reale, il Web è un’altra realtà: uno spazio di realtà aumentata. Credere che le cose vere siano offline e le cose disimpegnate siano online, ha lasciato, secondo me, spazio a un pericoloso retropensiero intuitivo: nel Web ci si può lasciare andare, togliere i freni inibitori. Ogni tanto si sente persino parlare ancora di “nativi digitali” - vocabolo sfatato dal suo stesso autore, Marc Prensky. Quel termine che indicava che la differenza tra chi sapeva "fare" nel Web e chi no, non dipendeva dall’educazione ma dall’età. Gli adulti erano quindi gli “immigrati digitali”, quelli che avevano appreso in parte a usarlo: la competenza digitale veniva misurata su basi essenzialmente tecniche. Si tratta di un’idea smentita dalla realtà dei fatti. Un bambino che, a 3 anni, sa già come sbloccare un Ipad, non vuol dire che sappia come si affronta la comunicazione nel Web. La competenza digitale non è soltanto informatica, ma è frutto dell’educazione. Il Sillabo del Ministero di cui parlavo prima cambia assolutamente approccio da questo punto di vista: per avere competenza digitale occorre educare alla responsabilità, significa insegnare come si stabilisce l’autorialità di una fonte, come si riconosce una fake news, come si comunica tra chi ha opinioni diverse. Così come non basta vivere in una società multischermi per sapere comunicare in modo corretto nel Web, non basta nascere in una società multiculturale per saper automaticamente gestire bene l’interazione con identità culturali diverse.
Anche noi, come Gariwo, siamo consapevoli di avere una responsabilità verso chi ci segue e legge i nostri contenuti. Come agire però di fronte ai fenomeni di hate speech? Esiste un modo giusto ed efficace?
Conoscere bene quelle caratteristiche del Web che portano più facilmente alla diffusione dei messaggi d’odio, la velocità soprattutto, è fondamentale per reagire in maniera efficace. Quando c’è un attentato di matrice islamista, parallelamente aumentano gli indicatori di islamofobia. In questi casi è importante reagire subito, con un hashtag alternativo per esempio. Come rispondo però a un insulto razzista? Direi senza fargli troppa pubblicità, come talvolta succede, ma lavorando, allo stesso tempo, perché si costruisca il cosiddetto counter speech, cioè un discorso alternativo. Non è la risposta a un preciso commento di odio che può fare la differenza, ma qualche volta è importante rispondere, dare un segnale, rompere la spirale del silenzio. Quando si interviene è significativo farlo in tanti, invitando tutti a rispondere.
Un fatto tipico dei social, a cui si deve fare attenzione, è lo spostamento del merito del confronto: insultare la persona intervistata, spostare l’odio su qualcuno che non c’entra nulla. Tenere il punto del discorso è fondamentale per aiutare chi interagisce a prendere sul serio ciò di cui si sta parlando. Di recente, la notizia della morte di una bambina rom, a soli due anni di vita, ha scatenato un fiume di commenti del tipo “una di meno”, “una ladra in meno”. È veramente credibile che tutti possano pensare una cosa del genere e siano pronti a confermarla? Non credo, però esiste una spirale di silenzio per cui quando percepiamo che la nostra opinione non è maggioritaria tendiamo a non intervenire, molto più che nell’offline. Aumenta la pressione di conformità. A volte, quindi, è davvero importante intervenire direttamente, senza partecipare alla canalizzazione della tensione, dicendo “attenzione, stiamo superando il limite”.



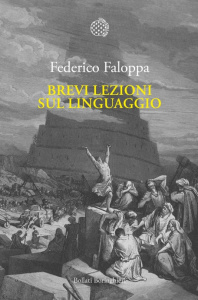
.jpeg)