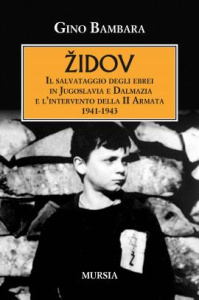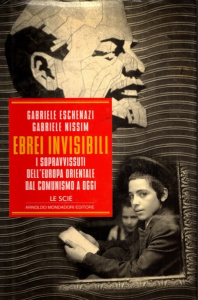La riedizione italiana del saggio di Hannah Arendt mostra, ancora una volta, la potenza del pensiero di questa intellettuale tra le più importanti del Novecento.
Il saggio, scritto nel 1943, in piena seconda guerra mondiale e due anni dopo il suo arrivo a New York, è stato redatto in inglese e di getto: c’è la sua esperienza esistenziale ma non è né una testimonianza né una riflessione dolente sul suo passato. È una denuncia politica fortissima: il suo punto di vista è quello di rifugiata e apolide cioè di un essere umano fuori dallo Stato e oltre il limite del diritto.
Nel bellissimo commento di Donatella Di Cesare, la curatrice sottolinea che la filosofa passa, in modo fluttuante, dal “noi” (perché si riconosce in tutti coloro che, salvati, sono decisi ad inserirsi nella nuova patria che li ha accolti) all’"io” quando, non concedendo nulla all’autocompassione, assume un atteggiamento critico rispetto agli atteggiamenti e alle attese degli esuli. Il saggio, nota Di Cesare, mette in scena “il dramma che si consuma tra il voi dei cittadini sospettosi, il noi dei nuovi arrivati pronti a tutto pur di assimilarsi, l’io della filosofa che si interroga su un altro possibile modo di dire”noi”, che serbi l’estraneità” (p. 65).
A questo “noi” si riferisce il titolo del saggio: “noi rifugiati” non indica il resto assimilabile del popolo ebraico ma i rifugiati come “l’avanguardia dei loro popoli purché mantengano la loro identità”, (p.30) l’anticipazione di una nuova comunità politica a venire.
Ma procediamo con ordine, ricordando alcuni episodi della vita di Arendt da cui sgorga la sua riflessione, sempre radicata nell’esperienza vissuta. La sua fuga, pericolosa ed estenuante da tutti i punti di vista, inizia nel 1933 quando deve lasciare la Germania nazista: fermata dalla Gestapo per la sua attività tesa a smascherare la propaganda del Führer, interrogata per 8 giorni e poi scarcerata, riesce a scappare priva di documenti, passando per Praga, Genova, Ginevra e Parigi. Del mezzo milione di ebrei tedeschi che lasciarono la Germania, circa 25000 trovarono rifugio in Francia: qui Arendt trovò alcuni amici (tra cui Hans Jonas), conobbe Walter Benjamin e incontrò Heinrich Blücher che divenne poi il suo secondo marito nel gennaio 1940. Mentre in Germania le cose stavano precipitando (annessione dell’Austria e Notte dei cristalli del 1938), in Francia, dopo la dichiarazione di guerra ai tedeschi del 3 settembre 1939, gli ebrei tedeschi esuli sul suolo francese furono considerati “stranieri indesiderati”. Dal 7 settembre un decreto ordinò che gli uomini fossero smistati nei campi di lavoro per contribuire allo sforzo bellico: anche Blücher venne trasferito a sud- ovest di Parigi. Quando le truppe naziste invasero il Belgio, il governatore di Parigi ordinò che anche le donne, provenienti della Germania, si radunassero al Vélodrome d’Hiver: Arendt dopo due settimane fu trasferita il 25 maggio 1940 nel campo di concentramento di Gurs, ai piedi dei Pirenei, al confine con la Spagna. Trecento baracche di legno, su una distesa di nuda terra recintata dal filo spinato, ospitavano fino a ventimila donne: condizioni igieniche terribili, vitto insufficiente, malattie rendevano il luogo degradato e brutale. Ma quello che rendeva la permanenza insopportabile era “la completa assenza di prospettive”, secondo la testimonianza di alcune sopravvissute.
Arendt non si è mai soffermata sulla descrizione della sua esperienza personale ma ne ha fatto l’occasione per una riflessione più ampia, politica: in “Noi rifugiati” tocca i temi della disperazione e del suicidio. Nella prefazione al libro di Bruno Bettlheim (Freedom from Ghetto) racconta come a metà giugno del 1940, quando la Francia della Repubblica di Vichy divenne un’alleata del regime nazista, approfittando di alcuni giorni di caos a Gurs, riesce a scappare con altre detenute, falsificando i documenti per il loro rilascio. Rintracciato, dopo un lungo cammino, il marito a Montauban, con rischio, astuzia e abilità la coppia riesce a Marsiglia ad ottenere il visto per l’America e giunge a New York il 22 maggio 1941 con l’etichetta di “apolide”(stateless) e tale Arendt rimase per lunghi 18 anni (dal 1933 al 1951, quando divenne cittadina americana).
Il saggio “Noi rifugiati” pone interrogativi brucianti per il mondo contemporaneo perché ipotizza che nel Novecento il rifugiato sia una nuova figura che non ha precedenti. Non è l’esule dei secoli passati, eroico nella lotta contro il potere che lo perseguita. In realtà l’esule e il rifugiato del Novecento hanno in comune solo l’esilio: senza aver commesso alcuna colpa, per il solo fatto di “essere nati ebrei” (direbbe Liliana Segre) l’ebreo rifugiato in fuga non sa dire perché ha dovuto lasciare casa, affetti, lavoro, lingua… Il rifugiato ebreo spera di sentirsi a casa nella nuova patria, ma ciò non avviene: chiede un rifugio senza poterlo motivare. Il distacco violento da ogni legame spinge molti al suicidio. Ma Arendt non vuole narrare i singoli drammi esistenziali, vuole riconoscere nella situazione del rifugiato un fenomeno politico.
Come annota Donatella Di Cesare “la vita dei rifugiati non è solo spezzata bensì è bandita, respinta ai margini della "polis", fuori dal mondo comune e condiviso, dove è grottesco continuare a parlare di patria. E’ una vita che galleggia fuori dalla storia, priva di legami, spoglia di relazioni… amondana o, se si vuole, acosmica. (p.69)
Se è vero, come la filosofia afferma da Aristotele in poi, che l’essere umano è zoôn politikón, come può esso sopravvivere fuori dal mondo, espulso non solo da una nazione ma in quanto rifugiato, vivere senza un posto nel mondo, indesiderato perché il mondo non sa cosa farsene?
Per Arendt quindi la storia contemporanea ha creato “una nuova specie di esseri umani, quelli che vengono messi nei campi di concentramento dai loro nemici e nei campi di internamento dai loro amici” (p. 6).
Con la lucidità che la contraddistingue, l’autrice afferma che “per la prima volta la storia ebraica non è separata da quella di tutte le altre nazioni; al contrario, è strettamente connessa. Il consesso dei popoli europei è andato in frantumi quando si è consentito che i membri più deboli venissero esclusi e perseguitati” (p. 30).
Non più solo destini dei singoli ma interpretazione politica di quella catastrofe: solo così, per Arendt, si può aprire una via di uscita.
Credo che questo sia il vero senso del fare Memoria: non c’è l’esclusiva né una graduatoria del dolore e della sofferenza umane. Se le vicende abissali del Male di cui la stessa Arendt è stata testimone e vittima assurgono ad una visione politica e filosoficamente universale, quel passato diventa capacità critica di leggere e agire nel presente.
Alcuni anni dopo il 1943, anno di pubblicazione del saggio, Arendt darà alle stampe una delle sue opere più famose, “Le origini del totalitarismo”(1951). Nel libro dedica alcune pagine ai rifugiati di tutto il mondo e afferma che, da quando gli Stati nazionali si sono spartiti il pianeta, facendo del territorio il loro possesso, si è prodotta tra un confine e l’altro una “schiuma della terra”, calpestata ma fluttuante e in continua crescita. La schiuma sono i senza patria, gli apolidi, i rifugiati intrappolati tra le frontiere, considerati “ rifiuti”, estranei, indesiderabili, superflui: è la nuova specie umana di quelle masse in fuga iniziata con la Prima guerra mondiale e il crollo dei grandi Imperi. Proseguita poi tra i due conflitti mondiali è arrivata fino a noi.
Di Cesare così commenta: “Il tentativo di conformare le frontiere degli Stati europei alle nazioni fece emergere una contraddizione profonda: l’impossibilità di assicurare i diritti a chi non fosse cittadino di una nazione. Il che era paradossale, dato che chi veniva condannato ad essere apolide, privato dei diritti garantiti dalla cittadinanza, avrebbe avuto semmai bisogno di essere più difeso e protetto”(p. 78) .
Per Arendt quindi l’apolidia diventa la grande questione della modernità perché è sia il risultato che l’oggetto del rifiuto degli Stati nazionali. Infatti quando gli Stati cercano di ottenere l’omogeneità della popolazione e il radicamento alla terra (criteri statici e restrittivi), “la nazione prende il sopravvento sul diritto, fa dello Stato il proprio strumento. In questa finzione, per cui la nascita diviene il fondamento della sovranità, Arendt scorge giustamente il declino ineluttabile dello Stato “(p. 79)… messo in discussione dall’esistenza delle minoranze e degli apolidi.
L’apolide, non essendo cittadino, perde i diritti umani considerati inalienabili.“L’apolide, nella sua nudità umana… sembra sfidare lo Stato…è inesiliabile perché nessuno lo accoglie. E’ l’indesiderabile per eccellenza” (cfr. Arendt, “Le origini del totalitarismo”, Einaudi Torino 2009, p.384).
Il problema è che gli espulsi dalla “vecchia trinità stato-potere-territorio” crescono sempre più e Arendt comprende che non è un problema di “spazio” ma di organizzazione politica. “Nessuno si era accorto che l’umanità, per tanto tempo considerata una famiglia di nazioni, aveva ormai raggiunto lo stadio in cui chiunque venisse escluso da una di queste comunità chiuse, rigidamente organizzate, si trovava altresì escluso dall’intera famiglia delle nazioni, dall’umanità” (Arendt, “Le origini….”, cit. p. 407).
Questo è palese nel caso dello Stato totalitario che arriva alla deportazione e all’eliminazione fisica ma, precisa Arendt, la differenza tra stato totalitario e stato democratico è solo di grado perché l’esclusione degli indesiderabili è caratteristica dello Stato nazionale che rende le zone di transito e i campi d’internamento una sorta di “surrogato di patria” per i rifugiati. Allora il problema centrale è quello dei diritti umani: come può accadere che a impedire l’accoglienza dei rifugiati siano quei diritti che dovrebbero invece realizzarla? Ciò accade perché, dalla Rivoluzione francese, i diritti dell’uomo sono stati pensati come diritti dei cittadini. Per Arendt manca quindi, nel Novecento, un diritto cosmopolitico che assicuri i diritti umani, cioè “il diritto ad avere diritti”, vero paradosso della democrazia.
Ne “La banalità del male” Arendt sottolinea che la Shoah è stata l’ultima tappa della politica dell’emigrazione (di cui Eichmann era stato Ministro) tesa a ripulire la Germania dagli ebrei: il principio teorico del suo crimine è stato “il diritto di stabilire chi deve e chi non deve abitare la terra" (Arendt, “La banalità del male”, Feltrinelli Milano 1997, p. 283-84). E questo è doppiamente un crimine contro l’umanità sia perché nega a un altro essere umano il diritto ad avere un posto nel mondo sia perché pretende di avere il diritto di decidere con chi abitare.
Oggi queste parole tuonano come un monito per le nostre democrazie: di fronte ai milioni di migranti e rifugiati per guerre, carestie, cambiamenti climatici… i cittadini europei di stati “sovrani" vorrebbero poter decidere con chi coabitare “immaginando che la cittadinanza equivalga al possesso della terra”. Ma, come sottolinea Donatella Di Cesare “prossimità non voluta e coabitazione non scelta sono le precondizioni dell’esistenza politica”. Come ricordava Arendt, rifugiati, stranieri e migranti hanno bisogno di una comunità d’accoglienza che non vuol dire Nazione ma una nuova comunità politica da immaginare e realizzare. Come direbbe Morin “una comunità di destino dell’umanità”, “una politica umanista” che riporti umanità e convivialità nelle nostre esistenze.